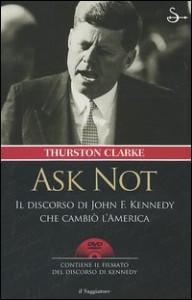La poderosa biografia che Peter Longerich – ben 890 pagine – ha dedicato a Joseph Goebbels è un tutto fuorché un mattone noioso. La minuziosa ricostruzione della vita del ministro della propaganda del Reich è, innanzitutto, un viaggio per comprendere come, un piccolo borghese con evidenti insicurezze al limite del patologico, è potuto diventare, insieme an accozzaglia non meno disturbata, uno dei padroni della Germania. Un viaggio nella mente di Goebbels che però non è un trattato di psichiatria ma un libro di storia con un imponente apparato critico ed una adeguata bibliografia. Certo è che la gioventù di Goebbles, complice anche la pressoché totale assenza di fonti, è indagata dall’autore molto più sui probabili processi psicologici che lo muovono che sulla semplice ricostruzione dei fatti. Per l’autore i complessi di inferiorità, fisica ma soprattutto sociale, sono la molla che spingono il neo laureato, scrittore fallito, a intraprendere la via della politica. Una strada che lo porta a trovare la sua guida, il suo idolo, in Adolf Hitler. Goebbels, questa la tesi, è sempre stato alla ricerca di un redentore – della sua posizione sociale, delle sue aspirazioni intellettuali che finisce per identificare in quelle dell’intera nazione tedesca – provando a immaginarsi egli stesso in tale posizione, per poi abbandonarsi alla figura di Hitler che riuscirà a mitizzare con la sua propaganda proprio perché lui per primo, lo considererà indispensabile.
Un processo di ricerca dell’approvazione del Fuhrer che segnerà e determinerà la vita privata del ministro della propaganda che, dopo una gioventù sentimentalmente tormentata, finirà per sposare Magda e con la quale instaurerà un ménage di cui Hitler sarà parte integrante e nel quale il dittatore finirà per prendere le decisioni significative (matrimonio, possibile divorzio) e che sosterrà anche economicamente.
Una simbiosi così profonda e perversa che porterà al tragico epilogo finale in cui i Goebbles, compresi i sei bambini, si toglieranno la vita dopo che Hitler avrà posto fine alla propria esistenza.
Ma la biografia, soprattutto dalla nascita del Goebbles politico sino alla tragica fine è una preziosa ricostruzione storica in cui si racconta dall’interno l’ascesa del nazismo, le lotte di potere, la frantumazione e il conflitto tra i gerarchi per finire con la condotta di guerra. Utilizzando i voluminosi diari del Ministro della propaganda, altro segno del suo egotismo, Longerich riesce a ricostruire e demolire l’immagine di potenza di Goebbles mostrandoci come almeno prima della fase finale del regime, Hitler giocasse con lui come il gatto col topo, lo escludesse dalle decisioni importanti convincendolo però del suo, successivo, ruolo fondamentale. O di come Goebbles provasse a sistematizzare posizioni autonome – la visione sociale del nazismo, il no all’alleanza con i conservatori per andare al governo, la sopravvivenza delle SA o la guerra totale – che venivano demolite dal Fuhrer facendo diventare il Ministro il più fervente sostenitore delle tesi a lui, fino a quel momento, opposte.
C’è poi Goebbles convinto antisemita nella suo progressivo passaggio da un antisemitismo borghese ad una ferocia non solo comunicativa indescrivibile; tuttavia cosciente che quegli atti, quelli della soluzione finale, significavano anche l’impossibilità per i nazisti e la Germania di tornare indietro, di salvarsi in qualche modo. Oppure il Goebbles che prova a imporre la propria idea di cultura nazionalsocialista finendo poi per ammettere, seppur nel solo privato dei diari, il fallimento nel creare una letteratura, un teatro, una musica e soprattutto, un cinema rispondente al regime.
Ne esce il ritratto di un uomo debole, tutt’altro che infallibile e onnipotente, incapace di una propria autonomia di pensiero, concentrato anche mentre tutto intorno rovina a ottenere l’approvazione del mondo e del suo capo. Una visione molto diversa da quella che il ministro era riuscito a conservare, nonostante il disastro finale, e che ci restituisce un altro pezzetto, non certo il più piccolo, della banalità del male e dei maligni.
Peter Longerich, Goebbles. Una biografia, Einaudi, 2016. Traduzione di Valentina Tortelli.
Articolo apparso su CulturaCommestibile n. 519 del 3 febbraio 2024