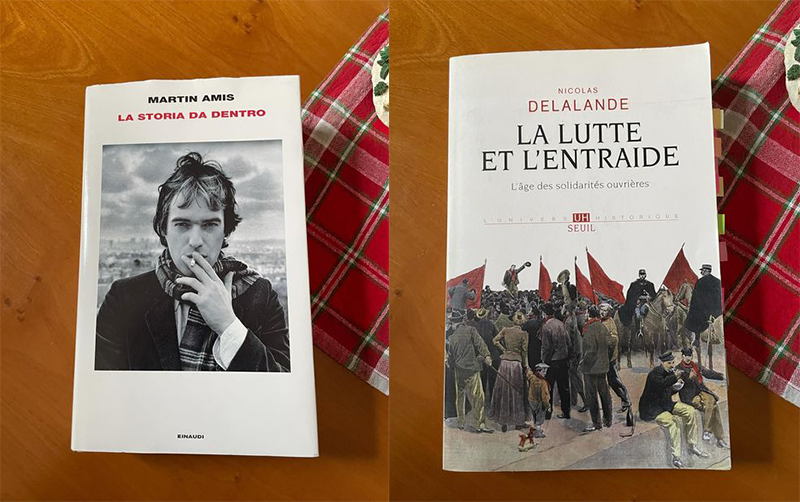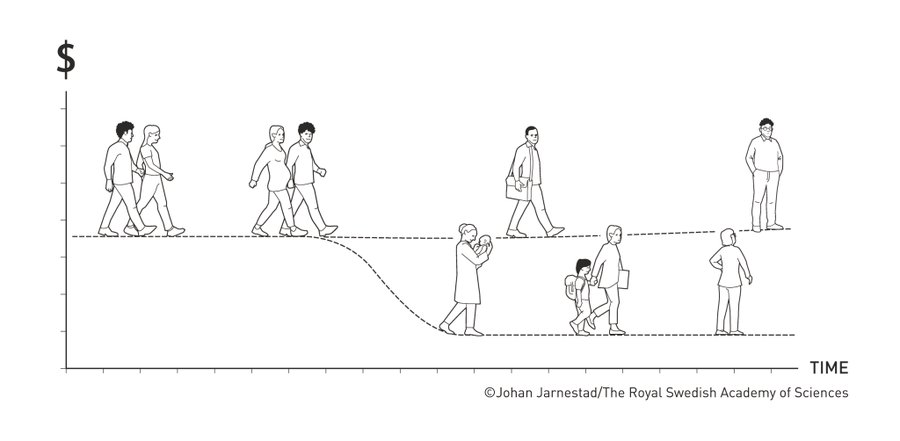La prossima settimana esce, per Derive e Approdi, il nuovo libro di Pippo Russo, L’estate di Totò Schillaci. Russo anni fa se ne uscì con un libro magnifico – Nedo Ludi – che parlava del cambiamento dell’Italia degli anni ’90, raccontando una storia di “resistenza” calcistica di un giocatore che rifiutava il passaggio dal calcio a uomo a quello a zona. Fu definito il miglior libro di calcio italiano ma era molto di più. Così come insegna Cartwright per l’Inghilterra, il calcio soprattutto tra gli anni ’70 e ’90 era un laboratorio sociale in cui si mostravano amplificate le nostre società europee.
Questo nuovo libro ritorna a quegli anni, segnatamente il biennio 1989 e 1990, ma il calcio, seppur presente a partire dal titolo, non è il centro del romanzo.
Il libro racconta Palermo, le sue classi sociali e quell’esperienza politica giovanile, l’ultima veramente politica e collettiva che fu “la Pantera”, l’occupazione delle università contro la riforma degli Atenei voluta dal governo Andreotti, partita proprio dalla città siciliana. Lo sfondo non è solo la città, ma un sistema politico locale e nazionale che – lo sappiamo ora – stava per andare in frantumi, così come le case demolite per far posto agli stadi del Mondiale del 1990, l’occasione di riscatto del Paese che fallì miseramente così come fallì quella Nazionale calcistica, predestinata alla vittoria, ma invece sconfitta in semifinale dall’Argentina.
In mezzo due comete che avrebbero potuto essere, ma non furono, come la Pantera e Totò Schillaci.
Ho avuto il privilegio di leggere il libro ancora in bozza e sono uscito dalla lettura scosso e commosso. Nel libro infatti c’è una malinconia pervasiva, un senso del tempo che non è senso di sconfitta, di resa. Appare più rispetto per sé, per un’esperienza politica collettiva, per una città e per le scelte della vita. Un rispetto a tratti orgoglioso, senza però essere mai iattanza.
La prima sensazione è di trovarsi di fronte all’altra faccia di Nedo Ludi, dove è il calcio a fare da sfondo al cambiamento generale di una città, un Paese, una generazione. Però in questo libro si va oltre; c’è una sofferenza personale avvertita, presente, in alcuni tratti soffocante. Sì perché il protagonista vive il proprio cambiamento politico, sociale, calcistico, ma anche personale in una storia d’amore che avrà i tratti dell’estate in cui tutto avrebbe potuto essere altro: la coppa del Mondo, la protesta studentesca, Palermo, il suo sindaco Orlando, la storia d’amore di due ragazzi distanti per censo e appartenenza.
Seppur Palermo sia, di fatto, un personaggio di questo libro, la dimensione di quello che vi si racconta va molto oltre i confini dell’isola. La Pantera non fu la mia generazione, io entravo al liceo nel 1989, ne sentivo echi lontani; l’impatto della politica avverrà più con il 1994, la discesa in campo di Berlusconi che avvenne però senza il conforto dell’ultima stagione collettiva della gioventù studentesca italiana. Eppure le pagine in cui viene descritto lo spegnersi del movimento, giudicandolo ma senza cattiveria, sono un preannunciare della stagione che avremmo, anche noi, vissuto.
Dopo quella stagione venne il trionfo della personalizzazione, vivemmo Berlusconi e i tentativi di fermarlo con “la gioiosa macchina da guerra”, capimmo però, forse meglio dire intuimmo, dal vestito marrone di Occhetto che la resistenza sarebbe stata vana.
Alla mia generazione mancava l’esperienza collettiva che proprio la Pantera aveva rappresentato; né, va detto, i più grandi che quell’esperienza avevano invece fatto, ci hanno voluto o potuto dire quello si trova nei capitoli finali del libro. Quel “prendere atto” di un esaurirsi della lotta, che forse non fu “impostura” o “tradimento” anche se, di sicuro, l’esito non fu quello previsto né voluto.
In L’età di Totò Schillaci questo viene descritto senza rimpiangere né disconoscere niente. C’è anzi l’affermazione della correttezza delle proprie scelte di allora, dato tale contesto e le informazioni disponibili, che non è assoluzione, ma consapevolezza delle scelte, una presa di coscienza si sarebbe detto nel lessico di una stagione che proprio allora viveva la sua coda.
Nel fare questo il protagonista, Enzo, non si fa sconti: non è un personaggio né risolto, né assolto. Russo tuttavia, non lo descrive mai come uno sconfitto, anzi il giudizio morale non è campo di gioco di questo libro ed è una grande forza che il volume porta con sé.
Accanto a tutto questo Totò Schillaci, la sua istintività calcistica che diventa metafora, il suo essere figlio disconosciuto di Palermo che pare accoglierlo solo nel momento della gloria, per poi dimenticarlo di nuovo. Schillaci svolge, nel libro, la funzione della tempesta nell’omonimo dramma shakespeariano: è motore dell’azione, in questo caso mnemonica, del protagonista senza neanche il bisogno di apparire in scena.
Con i ricordi del protagonista però, emergono anche i nostri, quelli di quell’estate che per Firenze fu ambigua. Da una parte il “boicottaggio” del tifo azzurro dopo il passaggio di Baggio alla Juventus e la finale di Avellino, la tracotanza di Matarrese capo della Federazione, i cori contro la nazionale. Dall’altra il tifo, semiclandestino, l’emozione di quegli occhi spiritati di Totò a segno partita dopo partita. Tutto questo riemerge nelle pagine del libro con la consapevolezza dei trent’anni trascorsi ma senza l’inacidirsi del nostro invecchiare, né la spocchia di chi oggi pensa di aver capito tutto a posteriori.
C’è poi un’altra cosa notevole in questo libro ed il trascorrere del tempo, le pagine hanno metronomi diversi, più rapidi nel passato, lenti al limite dell’immobilismo nella narrazione al tempo presente. In queste parti, quasi tutti trascorse su un balcone affacciato su Palermo, riecheggia il lento malinconico ritmo delle poesie di Vittorio Sereni. Una in particolare per me, Nel Sonno. Una poesia eminentemente politica in cui, anche lì, il protagonista faceva i conti con la disillusione della Resistenza nell’Italia repubblicana dominata dalla DC, in quel caso ascendente, mentre in questo libro ne viene descritta la fase terminale. Questo tempo sospeso così malinconicamente attraente è uno dei grandi meriti, per me, del libro.
Infine il libro ci regala anche una coppia di personaggi, Andaloro e Puleo, che svolgono una funzione classica a mezzo tra il coro greco e i Rosencrantz e Guildenstern di Tom Stoppard, in quel capolavoro omonimo che ribalta e svela l’Amleto.
Insomma L’estate di Totò Schillaci è davvero un gran bel libro, come ne capitano davvero pochi, e non lo dico per l’affetto e la stima che mi lega all’autore. No, in questo libro chi ha vissuto quelle stagioni troverà il ricordo e la messa in discussione di una stagione che pareva portare con sé riscatto e rinnovamento, chi è venuto dopo può riflettere sulle svolte, personali e collettive, che certe stagioni portano con sé, su fatto che talvolta un gol o un’assemblea avrebbero potuto cambiare tutto.
Pippo Russo, L’estate di Totò Schillaci, Derive e Approdi, 2025.
Articolo apparso su CulturaCommestibile n. 581 del 21 giugno 2025