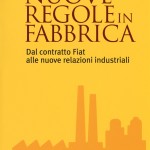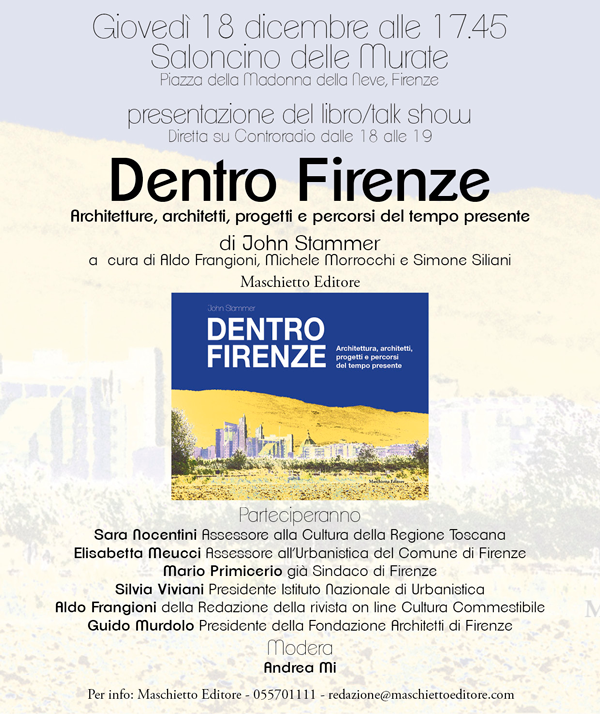Il paradosso della vicenda che ha visto Fiat, ora FCA, contrapporsi ai sindacati ed in particolare la FIOM sta nel fatto che nel momento in cui l’azienda esce dal sistema confindustriale e si fa un contratto di lavoro per sé, per la prima volta nella sua storia aziendale, diventa l’elemento trainante dell’intero sistema delle relazioni industriali italiane. Questo è uno dei punti che il libro di Paolo Rebaudengo, Nuove Regole in fabbrica (il Mulino 2015), affronta raccontando la vicenda che, dalla fabbrica di Pomigliano, ha portato la fabbrica torinese a creare un nuovo modello di rapporto con i sindacati e i lavoratori. Una delle tesi del libro, per tornare al paradosso, è che la FIAT neanche con la marcia dei 40.000 aveva mai davvero cambiato regole e liturgie del confronto sindacale e che soltanto la vicenda Marchionne Landini ha smosso un moloch tutto italiano. Paolo Rebaudengo non è un soggetto neutro della vicenda essendo stato per anni il direttore delle relazioni industriali di FIAT e il suo è un racconto dichiaratamente di parte. Proprio questo lo rende, forse, ancora più utile. Perché la vicenda FIAT è stata letta dalla grande stampa spesso in modo strumentale (di entrambe le parti a differenza di quanto afferma l’autore per il quale tutta la stampa sarebbe stata schierata con la FIOM) e mai nel merito delle vicende. Tuttavia il libro, pur essendo molto utile agli addetti ai lavori, è pensato anche per un pubblico più vasto perché indaga quello che molto probabilmente sarà lo scenario, quanto meno di confronto, tra lavoratori e imprese. Il dato di partenza infatti del libro e della vicenda viene posizionato non in un bisogno di risparmi e di contrazione dell’occupazione ma dal bisogno di FIAT di diventare un soggetto globale. Per farlo, l’organizzazione del lavoro, era e resta un elemento imprescindibile a partire, dice l’azienda, dalla misurabilità e comparabilità dai dati della produzione. Insomma la globalizzazione entra in fabbrica, pesantemente, ridefinisce uno dei terreni di scontro classici tra capitale e lavoro: l’ufficio tempi e metodi. Da questo oltre che da un bisogno di risposte quasi in tempo reale dell’impresa alle sollecitazioni di mercato discende la riforma delle relazioni industriali che diventano da accessorio delle risorse umane, parte integrante delle strategie di investimento dell’impresa e del gruppo internazionale. Su questo il confronto coi sindacati e con un certo sindacato in particolare non può essere più distante. E’ distante per cultura e, verrebbe da dire, per dimensione di riferimento. Non è un caso che la battaglia da sindacale si sposti quasi subito sul piano legale, dove le fortune dell’azienda sono molto meno certe che in fabbrica e, va detto, tra i lavoratori che hanno sempre approvato i vari accordi. Dunque un sindacato che, da parte aziendale, viene visto come un elemento non capace di capire i tempi attuali della produzione ma attaccato soltanto al diritto e alla sua funzione politica generale. Senza sposare in pieno la tesi aziendale (il sindacato deve essere anche agente politico/sociale e il conflitto esiste e dunque va governato) appare evidente una difficoltà esplicita del movimento sindacale a entrare in contatto in primis con gli strumenti culturali di questi tempi, apparendo come legato a logiche e manifestazioni non più rispondenti al proprio scopo sociale e finendo in alcuni casi, come quello della FIOM, a far sembrare prevalente l’aspetto politico orizzontale su quello della difesa e dello sviluppo dell’occupazione e della qualità del lavoro. Non sono però lesinate critiche anche alle organizzazioni datoriali in particolare Confindustria, dalla quale FIAT per firmare un proprio contratto è costretta ad uscire, vista comunque come un elemento conservativo e ritardante del processo di espansione del gruppo. Un libro interessante, infine, per la sua visione di prospettiva; perché lo scenario che si intuisce al termine di questa stagione vertenziale in FIAT è un modello sul quale si discuterà nei prossimi anni, un modello fatto di meno rappresentanza nazionale, di maggiore contrattualità aziendale, forse di contratti unici di “cornice” e di un nuovo rapporto tra aziende e sindacati fatto meno di principi e più di tecnicalità e dell’espansione di rapporti e interlocutori internazionali. Trovarsi pronti a questa stagione, da ambo i lati, sarà utile alle imprese e ai lavoratori.
Articolo apparso su www.culturacommestibile.com n.137 del 19 settembre 2015