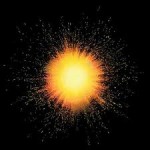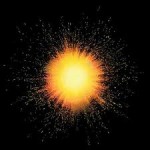
Siccome sono un po’ di giorni che i miei dieci lettori mi fanno troppi complimenti per quello che dico nella sintesi dei 140 caratteri di twitter, sento l’urgenza di fare arrabbiare un po’ tutti mettendo giù qualche nota sparsa sulla situazione politica e sugli ultimi estenuanti 60 giorni delle istituzioni politiche italiane. Nessuna pretesa di esaustività, anzi, né di una logica tra, e in, quello che scrivo. Giusto un po’ di pensieri sparsi da offrire e facilissimi ad essere smentiti persino nei prossimi minuti. Un’unica avvertenza di metodo, soprattutto a me stesso, nessun interesse al contingente, sia esso il governo, il destino di questo o quello o gli appuntamenti interni alla vita dei partiti, ma solo temi generali come si compete ad uno spettatore interessato.
1) La generazione playstation. Ho sempre pensato che la fila fosse sinonimo di civiltà; si trattasse di prendere un autobus, fare un prelievo al bancomat, progredire all’interno di una organizzazione sociale. Oggi invece, anche a causa di un paio di generazioni messe a tappo dell’intera società italiana (i meccanismi di cooptazione non hanno saputo adeguarsi all’allungamento della vita), è diventato di moda saltare la coda e fare vanto della propria inesperienza, almeno in politica. Così non ci sogneremo mai di farci difendere in un processo penale in cui rischiamo la galera dall’ultimo dei praticanti di uno studio legale, abbiamo invece affidato buona parte della vita dei partiti e delle istituzioni a degnissime persone, spesso brave e preparate, che però hanno iniziato la loro esperienza politica un minuto prima (talvolta persino un minuto dopo) essere elette. Il fatto che tutto questo lo si sia ammantato di merito, intendendo per merito le capacità extrapolitiche che indubbiamente molti di questi nuovi protagonisti hanno, ai miei occhi risulta come aggravante. Così abbiamo oggi in molte istituzioni e partiti politici una generazione che non ha mai giocato davvero a calcio pensando che fosse sufficiente essere dei campioni alla playstation. Da qui una sottovalutazione delle prassi, delle liturgie istituzionali (la cui conoscenza è indispensabile se le si vuole sovvertire) che porta a innocue goliardate come votare Mascetti alla Presidenza della Repubblica (atto apparentemente innocuo ma significativo del clima da gita scolastica) o al pensare che male non farà dare un po’ di schede contro Prodi giusto per vedere l’effetto che fa. Solo che poi, mancando mestiere e regia, finisce che le schede sono troppe e tutto crolla.
2) Questione Morale o questione politica. Passi trent’anni a dirti la parte sana e migliore del Paese e finisce che non solo ci credi ma condisci ogni dissenso dal tuo bene comune come tradimento o crimine. Ci riflettevo ieri sera quando un giovane, evidentemente non anagraficamente figlio delle tradizioni politiche novecentesche, ha detto “noi siamo il PD buono”. Allora mi è tornato in mente Natta (che mi pare Guido Vitiello giorni fa ha ritrovato su facebook) che criticava l’intervista di Berlinguer sulla questione morale. Diceva Natta che Berlinguer aveva commesso un tragico errore nell’avere posto non una questione politica ma una questione morale. Oggi possiamo dire che aveva ragione e che il clima di odio (sì odio) che si avverte nella società prima che nei gruppi dirigenti è la dimostrazione che la spaccatura nel Paese non è tra linee politiche ma tra linee morali, il bene e il male (sia chiaro analogo discorso vale a parti invertite dove anche larga parte del popolo di destra odia la sinistra). Occorrerebbe che la politica abbandonasse il campo immediatamente e non impostasse campagne elettorali involontariamente orwelliane (l’Italia migliore) e lasciasse alla cultura e persino alle religioni il compito di pacificare il Paese. Dovremmo impegnarci a farci almeno un amico (virtuale o reale) della parte avversa e conoscendolo vedere che ci somiglia molto più di quanto ci divida la scelta politica. Occorrerebbe anche rivalutare Natta, se non politicamente almeno culturalmente. Un operazione che la trasformazione in santino di Enrico Berlinguer ha sinora impedito. Penso e spero che a partire da quell’articolo che citavo presto qui o su qualche rivista possa proporvi una rilettura di Natta e della sua “diversità”.
3) Un partito in Barca. Ho letto il documento di Barca. Occorrerà tornarci e discuterne approfonditamente. Conto di farlo da queste parti appena avrò un po’ di tempo per scrivere seriamente. La prima impressione è quella intanto di un metodo nuovo, seppur antico. Non ci si è limitati a una brochure colorata o una infografica ma si è scritto un saggio di 55 pagine con note e bibliografia. C’è fatica e c’è rispetto in siffatta maniera. Sul piano dei contenuti però la prima cosa che salta all’occhio è il tentativo, non proprio modernissimo, di coniugare Gramsci con Amartya Sen. Mi verrebbe da dire si accomodi. Sono circa venti anni che ci hanno (abbiamo se mi passate l’immodestia) provato. Ogni volta però il limite è stato di prendere in Gramsci le parti relative all’organizzazione e al partito e in Sen le parti economiche. Forse occorrerebbe prendere la lettura della società di Gramsci e il concetto di politica che deriva dalla declinazione di Libertà di Sen perché l’esperimento abbia buoni frutti.
4) Divergenze tra me e il compagno Pannella. Criticare Marco Pannella non è mai operazione semplice, non tanto per la sua grande storia ma per la sua capacità spesso divinatoria di leggere la politica e la società italiana (una volta magari riusciti a dipanare qualcuno dei mille rivoli della sua oratoria). Però sulle sue critiche al presidente Napolitano mi spiace ma (per quel che conta) non sono d’accordo. Pannella parte dal condivisibile punto che Bonino sarebbe stata meglio di Napolitano e ne addita responsabilità anche allo stesso Napolitano. Certo il Presidente ha fatto un (grandissimo) discorso di (auto)investitura molto assolutorio verso se stesso e come lui ha inteso e agito la sua carica istituzionale nel primo settennato. Quello che però contesto a Pannella è una tendenza egualmente assolutoria nei confronti del suo partito (o della sua galassia). Ok il regime, ok la partitocrazia imperante ma forse causa dell’annientamento elettorale dei radicali è anche un gruppo dirigente tra i più immobili che il partito ha avuto nella sua lunga e gloriosa storia. Perché la partitocrazia e il regime sono ovunque ma in Puglia le firme le raccolgono nel nord no. Sia chiaro stiamo parlando di persone serie, preparate e con una passione e un impegno smisurati, tuttavia non capaci, a mio avviso, di essere nuovi, innovatori, come sempre sono stati i radicali. E non c’entra nulla la storiella di Pannella che mangia i suoi figli, Pannella quando dissente semplicemente si ferma e come ogni stella intorno alla quale ruotano sistemi solari, quando si bloccano i corpi celesti collassano su sé stessi. Credo che per il bene dei radicali (e dunque dell’intero Paese) una nuova fase politica di quel soggetto sia necessaria, aldilà delle figure e delle persone che la incarneranno.
5) Avanti il gran Partito. Collegandomi con quanto scritto sopra l’ultimo punto lo dedico al PSI di Nencini. Nel marasma generale quel partito mi è apparso, almeno nel centrosinistra, la forza politica che meglio esce da questi 60 giorni di delirio. Una posizione coerente sul Presidente della Repubblica, nessun tradimento dell’alleanza e dei suoi leader e una posizione chiara sul governo. Certo, direte, è facile farlo quando non si è determinanti ma anche avere coscienza dei propri limiti è grande pregio per una politica in cui abbiamo visto partiti del 3% pretendere propri esponenti alla guida delle istituzioni, dettare linee di governo e pontificare sempre e comunque. Certo non dimentico che Nencini è quello dell’accordo in cassaforte con Manciulli o quello che mentre faceva le manifestazioni contro la riforma della legge elettorale per le europee perché estrometteva i piccoli partiti, contemporaneamente votava la riforma del “cinghialum” toscano che provocava lo stesso effetto. Tuttavia in questa fase, per me, si è ben mosso e la sua proposta di rimettere in piedi un ragionamento sulla sinistra laica e socialista mi pare una vecchia novità necessaria non per dar vita all’ennesimo partitino ma perché quelle tradizioni non siano assenti da questo (speriamo non infinito) dibattito.