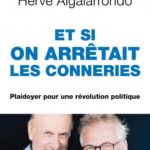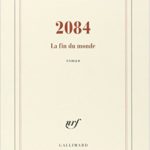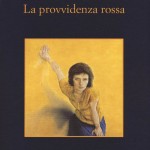Oggi è l’undici di agosto e a Firenze si dovrebbe celebrare solo una cosa, la sua Liberazione. Le donne e gli uomini, autoctoni o venuti dalla parte “giusta” del mondo a liberarla. Invece ieri a Firenze è piovuto. Per circa 15 minuti è piovuto forte ed è tirato molto vento. Non è venuto un tornado, né una tromba d’aria. No è piovuto parecchio. Come capita da sempre in estate. E’ capitato anche che un albero è venuto giù, non ha colpito nessuno ma è venuto giù. Un albero grosso, che stava in quella strada (la strada dove sono nato sia detto per inciso) con tante foglie verdi. Un albero che avresti detto sano e rigoglioso. E infatti i cittadini della mia strada (non abito più lì da tanto ma insomma è sempre casa mia) hanno fatto un gran canaio perchè il Comune, brutto e cattivo, non buttasse giù lui e gli alberi a lui vicini perchè “Dio bono e si vede a occhio che son sani”. A occhio eran boni ma un temporale estivo l’ha buttato giù e per fortuna non si è fatto male nessuno. Dunque aveva ragione il Comune, i suoi tecnici, e chi di mestiere guarda gli alberi e decide (o almeno dovrebbe) che vanno “cambiati” perchè gli alberi non sani vanno giù. Vanno giù anche nei boschi, sia chiaro, ma penso che tutti si possa notare la differenza tra un albero che cade in un bosco e uno che cade tra le vie di una città. Quindi il tecnico del comune che guarda gli alberi del quartiere 5 (sia detto sempre per inciso che è uno pure simpatico) ha fatto bene il suo mestiere e ha detto che l’albero andava tagliato e sia dato atto che non lo ha fatto per un bieco interesse corruttivo di far girare gli alberi, come l’Avvocato invocava di far girare la patonza. No l’ha fatto perchè sa fare bene il suo mestiere. Meno bene, mi sia concesso, ha fatto il Comune che di fronte alla protesta ha posticipato il taglio di quegli alberi e dunque farebbe meglio a non dire che si è “sfiorata una strage”, perchè un po’ di colpa, fosse davvero successo qualcosa, l’avrebbe anche l’amministrazione posticipante. Ma torniano agli alberi. Non è la prima volta che a Firenze, e in quella zona, sugli alberi si fanno discussioni e azioni. Per il taglio degli alberi sul tragitto della tramvia c’è chi ci si è appollaiato e chi si è incatenato (ad un albero che non sarebbe stato abbattuto ma questo è un particolare); ricordo anche qualcosa su un nido di uccelli che pareva essere l’ultimo avamposto di una specie ormai prossima all’estinzione e invece pare fosse in disuso da anni. Insomma i miei vicini agli alberi ci tengono, li considerano un elemento immutabile e naturale della città. Non si toccano sono lì da sempre, dicono. Non è così ma anche i più anziani che si ricordano che quell’isolato erano tutte fabbriche e campi fino a quaranta anni fa, si voltano da un’altra parte e brontolano. Gli alberi in città sono un prodotto dell’uomo, come tutto il resto. Spesso risentono più della stagione politica che di quella metereologica. I famosi alberi di viale Morgagni erano una parte del parco della rimembranza, cioè il frutto di una legge del primo dopoguerra che imponeva, per ogni caduto della città sui campi di battaglia, fosse piantato un albero a suo ricordo. Dati gli anni e il sopravvenuto regime fascista invece di boschetti si diede vita a viali alberati su cui far marciare la prossima generazione di soldati da spedire alla prossima guerra. Ma anche le essenze che popolano i nostri giardini hanno dovuto fare i conti col regime. Se mi affaccio dalla mia terrazza mi trovo davanti una collezione di palme da fare invidia a Malindi. Il quartiere dove abito adesso, fu infatti edificato sul finire degli anni ’30 e la moda botanica dell’epoca era in linea con le celebrazioni del neonato impero. Si chiamavano i figli Impero e si piantavano palme nei giardini. Mica solo a Firenze o più a sud, se passate dal quartiere piacentiniano di Bolzano e date una sbirciata nei giardini delle case troverete anche lì qualche palma sopravvissuta ai rigori dell’inverno. E’ solo da un breve lasso di tempo che la flora delle città non è più affare da architetti (categoria spesso molto zelante con la moda e col potere) ma sono diventate affare da botanici e agronomi. Come il signore che guarda gli alberi del quartiere 5 e che aveva detto che quell’albero, a occhio sanissimo, non stava tanto bene. Eppure finche si piantavano palme sulle alpi andava tutto bene e quando un tecnico ci dice che quella pianta non sta bene formiamo un comitato. C’è chi dice che sono le storture della democrazia e spesso lo dicono quelli che la democrazia ce l’hanno antipatica. Poi ci sono quelli che “voi non capite un cazzo, io ho studiato dovete seguire me, perchè sono un Professsore”, che come dice il mio amico filosofo Boem, non servono a molto. E poi ci sono gli intellettuali (in un accezione ampia e diffusa, anche collettiva alla Gramsci che sarebbe il caso di approfondire ma magari non qui) che semplicemente o hanno smesso di studiare, o hanno smesso di impegnarsi o hanno smesso di parlare alla gente. E si autocommiserano quasi fossero una setta decadente millenarista che invece che credere che la terra sia piatta la credono tonda ma non per colpa degli ebrei (peraltro sono diversi giorni in cui mi interrogo sul cosa ci guadagnerebbero gli ebrei a far credere che la terra è sferica come dicono i terrapiattisti). Insomma alla fine parlando di alberi son finito a parlare di Libertà e quindi ho seguito il precetto iniziale sperando così di aver celebrato l’11 agosto che per noi fiorentini è, forse, il giorno più bello.