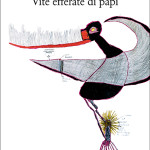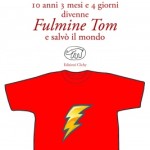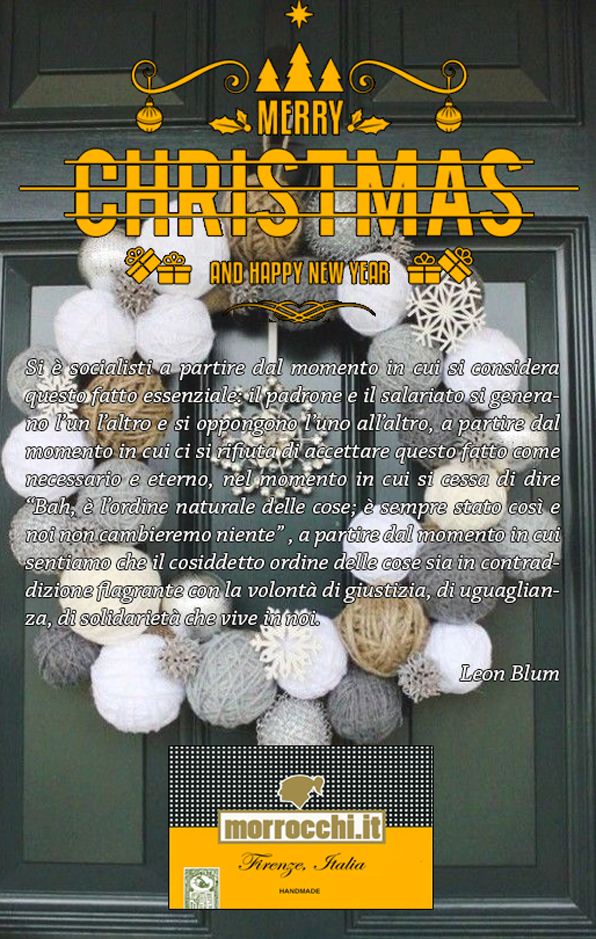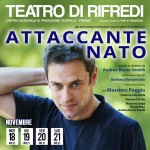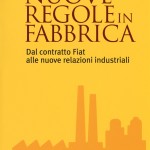La lotta di classe non è conclusa come spesso ci dicono. Non si combatte nemmeno solo nelle periferie o davanti ai cancelli dei magazzini della logisitica.
Vi è una lotta di classe quotidiana, non violenta ma non per questo non cruenta, che si combatte, per esempio, nel centro storico di Firenze. Una lotta di lunga durata, ininterrotta, che vede ormai soccombere proletariato, borghesia liberale e semplici cittadini. Una lotta che non vede cambiamenti significativi di fronte da quasi sempre e che ha avuto, la più recente, battaglia decisiva nella pedonalizzazione di Piazza Duomo e soprattutto nell’impedire il passaggio della tramvia dal centro storico. Un’operazione che ha portato a dare un limite, un perimetro, al centro storico, favorendone la trasformazione in compound. Ennesimo processo di gentrizzazione, isolamento: il ghetto del bello, usufruibile formalmente a tutti, ammiccante in realtà a turisti e clienti. Una volta delimitato il perimetro si procede alla “pulizia”.
Ecco dunque l’ultimo tassello, il provvedimento contro i cosiddetti minimarket. Atto in cui elementi di Stato Etico si fondono con la brama del capitale (ché solo i rivoluzionari da tastiera confondono il capitale col liberismo e dimenticano che il primo ha sempre fatto migliori affari con gli statalisti che con i liberali) al suono di parole come decoro, salute, pulizia e bellezza. Un provvedimento talmente classista che ha fatto gridare al razzismo chi, ormai disabituato a usare categorie politiche, maneggia soltanto quelle sociali. Un intento e un pensiero che sappiamo estraneo ai nostri amministratori ma che la natura del provvedimento ha reso passibile di fraintendimento.
Il pubblico che torna a dare patenti di liceità: Tiger (quella simpatica catena di chincaglierie made in china) sì perché nordico e lindo, the king of Lahore no perché privo di lampade di design (spesso di lampade toutcourt) e diciamocelo piuttosto sudicio.
Una lotta in cui non ci è stato risparmiato, almeno per pudore del ridicolo, la retorica del cancro da estirpare, così maschia e virile. E’ in gioco la salute dei nostri figli! Quelli a cui abbiamo abdicato il nostro ruolo di educatori preferendo indossare la maschera più semplice (ma dozzinale) dei guardiani.
L’alcool quindi, il nemico, feticcio secolare dei proibizionisti di ogni risma. L’alcool come nemico della meglio gioventù, quella che si riprende il futuro. E ho tremato passando davanti a Procacci, con in vetrina le sue splendide bottiglie di ottimo Chianti. Anche lui un nemico? O forse saranno i tre bicchieri a garantirci come già fecero le stelle gialle?
Una siffatta battaglia poi è talmente perfetta che salda gli entusiasti del capitale, buttafuori addetti alla door selection su base censitaria, agli optimates del belllo. I tutori dell’arte e della bellezza, conservatori e tutelatori, progressisti reazionari che sognano un mondo di fruitori del bello a cui loro han dato educazioni e patenti di apprezzabilità. Pronti a brandire oggi la Costituzione Repubblicana come, ieri, brandivano il libretto rosso; non avendo probabilmente letto sino in fondo nessuno dei due.
Capaci di indignarsi per i manifesti sui restauri (e meno male) ma in fondo felici per la ripulitura dal piccolo minimarket africano, così fuori contesto.
Oggi più di ieri si avvertirebbe il bisogno di una Rivoluzione. Liberale.
Articolo apparso su Cultura Commestibile n.155 del 30 gennaio 2016.