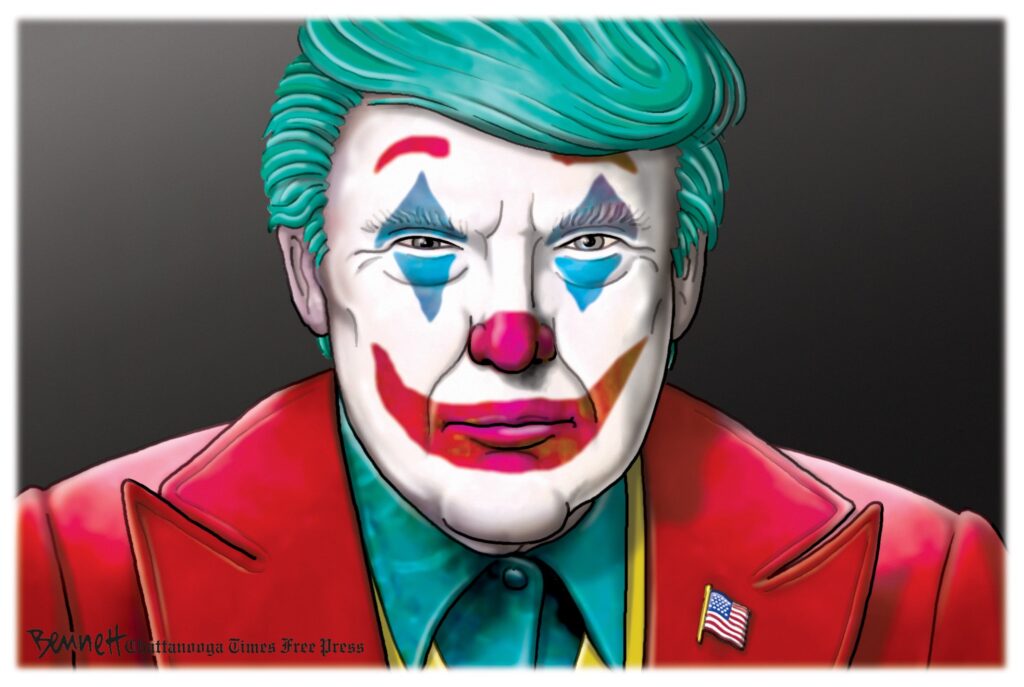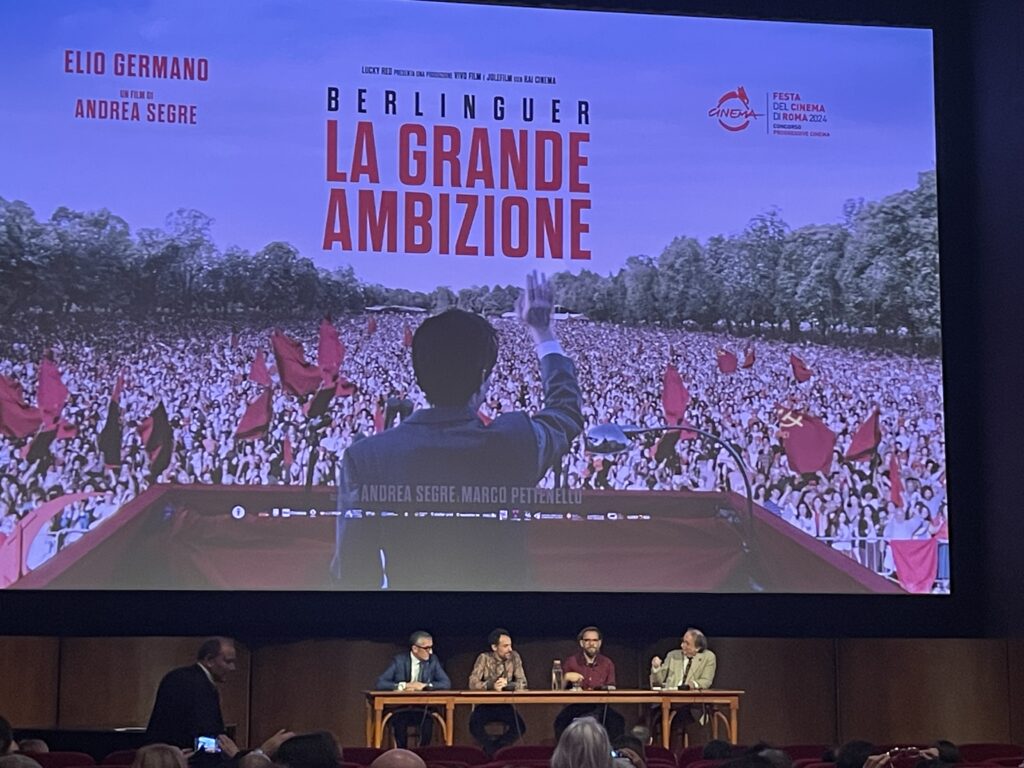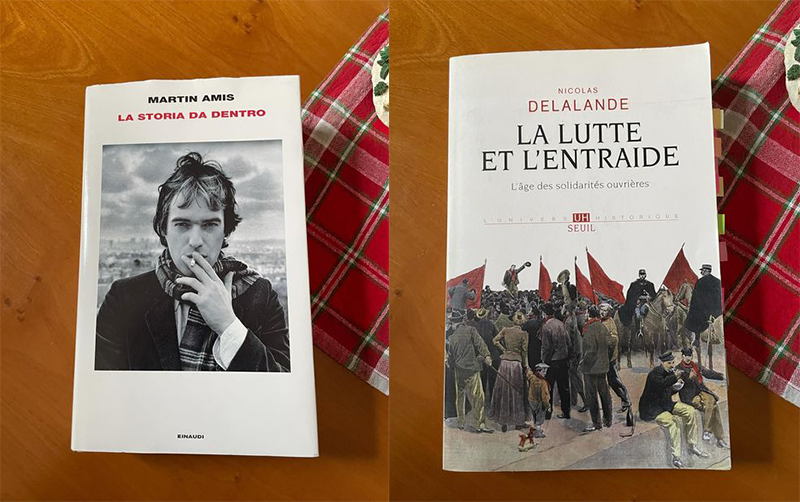Quando nel 1983 apparve per la prima volta “Ni droite ni gauche. L’idéologie fasciste en France” (in Italia pubblicato da Baldini&Castoldi nel 1997), il libro di Zeev Sternhell scosse la storiografia europea come poche opere avevano fatto prima.
L’oggetto dello scandalo era una tesi tanto chiara quanto destabilizzante: il fascismo non fu un accidente della destra radicale, né un’imitazione italiana o tedesca trapiantata altrove, bensì una vera e propria ideologia autonoma, nata da un’ibridazione tra nazionalismo e socialismo rivoluzionario, particolarmente feconda proprio in Francia.
Per Sternhell, il fascismo non nasce dall’arretratezza, ma bensì da un processo culturale che attraversa intellettuali e movimenti ben radicati nella modernità politica della fine del XIX secolo e degli inizi del XX.
La sua originalità consiste nell’aver colto come una parte della sinistra – disillusa dal proletariato, critico della democrazia parlamentare, alla ricerca di una nuova sintesi nazionale – abbia trovato un terreno comune con la destra nazionalista e tradizionalista.
Già alla vigilia della Grande guerra, sostiene lo storico, “il fenomeno si era già formato ed era già dotato di un solido quadro concettuale”.
In questo senso, il fascismo appare non come un corpo estraneo, ma come una delle possibili risposte alla crisi della democrazia liberale e all’esigenza di una mobilitazione di massa.
È significativo che Sternhell individui nel sindacalismo rivoluzionario di Sorel, Lagardelle, Labriola e Michels una radice ideologica decisiva: la convinzione che la democrazia fosse “l’arma offensiva più efficace mai inventata dalla borghesia” e dunque che il socialismo, per realizzarsi, dovesse distruggere la democrazia stessa.
Il volume ha il merito di smascherare ciò che lo storico definisce la “banalità del fascismo”: un’ideologia diffusa ben oltre i circoli ristretti che se ne proclamavano eredi, penetrata nel discorso di intellettuali e politici rispettabili, che spesso nel dopoguerra avrebbero indossato i panni di liberali e democratici. “Gli uomini possono cambiare e hanno il diritto di farlo – scrive Sternhell – non hanno invece il diritto di distorcere la propria storia e quella del loro tempo”.
Quello che però internessa l’autore è la ricerca di radici profonde nella società francese delle pulsioni fasciste, intese come un fenomeno prima di tutto intellettuale, capace di penetrare ben oltre la cerchia di pochi fanatici. E non importa, sostiene lo storico, che il fenomeno in Francia non si sia compiuto se non a seguito della disfatta del 1940; anzi è prorio il suo essere fenomeno non macchiato dalla prassi del potere a rendere ancora più “universale” la sua capacità di penetrazione.
Inolte il caso francese mostra come sia proprio la mancanza di una “Destra” classica e strutturata ad aver favorito il passaggio dalla teoria fascista e nazista alla pratica del loro governo e che, invece, dove la Destra era in grado di mettere in campo una propria dimensione ideologica, organizzativa e politica, come in Francia, il fascismo si era “limitato” ad essere una pericolosa ideologia.
Il punto più controverso del libro sta nella sua radicalità: il fascismo come sintesi rivoluzionaria “né di destra né di sinistra”, espressione di un socialismo nazionale e corporativo che rifiuta sia la lotta di classe sia l’individualismo liberale.
Una visione che spiega, per esempio, la traiettoria del “neo-socialismo” francese di Déat, dove “l’antimarxismo, la solidarietà fra le classi nell’ambito della nazione e la volontà di costituire un sistema corporativo formano un insieme ideologico originale”.
La ricezione del volume fu durissima. Storici come René Rémond o Serge Berstein contestarono l’idea che la Francia avesse fornito un terreno privilegiato al fascismo, insistendo sul suo carattere marginale e “importato”.
Altri, come Ernst Nolte, ribadirono la natura essenzialmente antimarxista e reazionaria del fenomeno.
Sternhell, al contrario, insisteva sulla forza attrattiva che il fascismo ebbe come promessa di “rivoluzione morale e spirituale”, capace di affascinare intere generazioni in cerca di un “fare del nuovo”.
A più di quarant’anni dalla sua prima pubblicazione, Né destra né sinistra resta ancora un libro scomodo e imprescindibile.
La sua forza sta non solo nell’aver ridefinito la genealogia del fascismo europeo, ma anche nel richiamare con forza il dovere della memoria critica.
Come sottolinea Maria Grazia Meriggi nella postfazione, Sternhell ricorda ai lettori che il pluralismo e il conflitto delle idee proprie della democrazia liberale affondano le radici in conflitti materiali e storici mai definitivamente risolti.
Ed è in questa tensione irrisolta, più che nelle formule politiche, che si misura ancora oggi l’attualità della sua lezione.
Dunque perché leggere oggi, di nuovo Sternhell? Se il fascismo “esercitò allora un’attrazione molto più profonda di quanto non si voglia oggi riconoscere” fu perché una nonj ristretta coorte di intellettuali lo vide come “lo strumento di una rivoluzione morale e spirituale radicale”. Riconoscerne il suo “fascino” ci permette di non ridurlo, macchiettisticamente, al ritrovo di un manipolo di reduci in un buio teatrino Milanese, guidati da un leader solo e carismatico.
Il caso francese ci dimostra come la pulsione rivoluzionaria, giovanile, la “volontà furibonda di fare del nuovo” covavano nella società a Destra come a sinistra e che fu, per certi versi, facile appiccare l’incendio. Anche perché, ed è forse la lezione più attuale, tutti questi “ribelli” riconobbero come nemico comune la democrazia liberale. Un istituto che anche oggi non gode di ottima salute.
Articolo apparso su Cultura Commestibile, n. 590 del 04 ottobre 2025